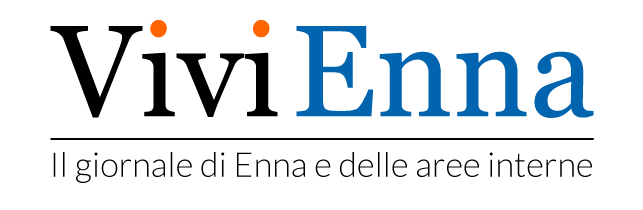Le riserve naturali in provincia di Enna
Enna-Provincia - 03/04/2013
Riserva naturale monte Capodarso e Valle dell’Imera Meridionale
 Questa riserva naturale orientata si estende su di un territorio di ben 1.485,1 ettari (679,7 di Zona A e 805/3 di zona B).
Questa riserva naturale orientata si estende su di un territorio di ben 1.485,1 ettari (679,7 di Zona A e 805/3 di zona B).
Le grandi dimensioni della riserva, posta a cavallo tra la provincia di Enna e quella di Caltanissetta, nei comuni di Pietraperzia, Enna e Caltanissetta, ne fanno una delle maggiori aree protette dell’isola.
Già negli anni settanta veniva a gran voce reclamata la necessità di proteggere il corso centrale del fiume da speculazioni, cave e cementificazioni di ogni sorta.
Nonostante questo forte movimento di opinione la vallata venne però deturpata dalla realizzazione della strada di scorrimento veloce Caltanissetta-Gela, svettante con i suoi viadotti proprio lungo il corso del fiume.
Oggi, dopo l’agognata istituzione e l’affidamento, la vallata è protetta dall’altezza della stazione ferroviaria di Imera, lungo la linea ferrata Catania-Palermo, al ponte di Bésaro, a Sud.
Qui si trovano le gole di Capodarso ed una serie di magnifici ambienti naturali, non solo fluviali, che costituiscono un forte elemento di richiamo per gli amanti del turismo d’ambiente. Ampie gorene, con meandri e pozze di acqua salata, tale è l’acqua del fiume, sono habitat per diverse specie ornitiche sia di passo che stanziali, tra le quali le folaghe, le gallinelle d’acqua, diversi ardeidi, ma anche di rettili ed anfibi, mammiferi e centinaia di specie di invertebrati.
 Nei mesi primaverili ed estivi, non è raro incontrare la testuggine palustre (Emys orbicularis) che si nasconde tra la vegetazione acquatica per sorprendere le sue prede. La riserva, facilmente raggiungibile sia da Enna che da Caltanissetta, difende anche alcuni tra i maggiori siti della civiltà mineraria siciliana: la vallata, spettacolare con le due cime di Capodarso ad est e Sabucina a ovest, popolata sin dalla più remota antichità, ha scavato i depositi dell’altipiano gessoso solfifero sino a favorire la coltivazione di miniere di zolfo su ambedue le rive.
Nei mesi primaverili ed estivi, non è raro incontrare la testuggine palustre (Emys orbicularis) che si nasconde tra la vegetazione acquatica per sorprendere le sue prede. La riserva, facilmente raggiungibile sia da Enna che da Caltanissetta, difende anche alcuni tra i maggiori siti della civiltà mineraria siciliana: la vallata, spettacolare con le due cime di Capodarso ad est e Sabucina a ovest, popolata sin dalla più remota antichità, ha scavato i depositi dell’altipiano gessoso solfifero sino a favorire la coltivazione di miniere di zolfo su ambedue le rive.
Riserva naturale orientata del monte Capodarso e della Valle dell’Imera MeridionaleNacquero così la miniera di Trabonella e su quella ennese il complesso minerario di Giumentaro e Giumentarello. Con il crollo del mercato dello zolfo siciliano e con il progressivo smantellamento dell’EMS, i due complessi minerari vennero abbandonati ed oggi sembra quasi che i lavoranti, i “carusi” di un tempo, siano fuggiti poche ore prima da chi sa quale minaccia, lasciando sul terreno i cumuli del materiale grezzo, gli utensili, i registri paga, le auto, i mezzi sotterranei.
L’atmosfera, certamente apocalittica, è quella dell’incomprensibile capacità siciliana di dimenticare la propria storia, oggi, tra queste rovine archeologiche di soli vent’anni fa, si aggirano frastornati studenti in visita che, pur essendo figli e nipoti dei minatori, non hanno più alcuna idea di cosa possa celarsi dentro questa terra aspra ma ad un tempo generosa.
L’altura di Capodarso, magnifica con la sua lunghissima rocca calcarenitica di colore ambrato, spettacolare al tramonto, nasconde cavità carsi che inesplorate, delle quali un piccolo assaggio è dato da ciò che resta della “Grotta delle Meraviglie”. Inoltre i resti di un centro indigeno ellenizzato, che del monte occupava la cima e del quale rimangono in vista migliaia di cocci ceramici, un muro ad aggere ed una misteriosissima e scenografica scala che scende per alcuni gradini per poi proiettarsi nel vuoto della rocca che guarda a nord ovest.
Nessuno ha sinora compreso il significato di questa scala, forse simbolico tragitto verso mondi sovrannaturali o luogo di supplizi, forse, ancora, via di fuga un tempo dotata di corde e scale a pioli.
Riserva naturale orientata del Monte Altesina
 Il Monte Altesina, si chiamava in antico Mons Aereus, (il monte aereo), probabilmente per via della sua forma svettante che lo innalza dal fondovalle con una forma puntuta visibile e riconoscibile da gran parte della Sicilia centrale.
Il Monte Altesina, si chiamava in antico Mons Aereus, (il monte aereo), probabilmente per via della sua forma svettante che lo innalza dal fondovalle con una forma puntuta visibile e riconoscibile da gran parte della Sicilia centrale.
Esso venne preso persino a pietra di paragone per l’altezza nonostante non raggiunga i milleduecento metri sul livello del mare. Nei paesi vicini è ancor’oggi facile sentir dire “gatu quantu l’Artisina”, alto quanto l’Altesina.
La sua forma facilmente traguardabile, oltre alla sua posizione centrale, consentirono agli arabi di sceglierlo quale punto trigonometrico principale in Sicilia, e da esso fecero dipartire i tre Valli, le tre regioni amministrative che dividevano la Sicilia in età emirale e che rimasero tali sino alla decadenza del feudalesimo nel XIX secolo.
Sulla cima, almeno dall’età del bronzo, si stanziarono popolazioni indigene dedite alla pastorizia e protette dall’acclività dei versanti. Qui, tra le guglie rocciose erose dagli agenti atmosferici e lavorate dall’uomo, le ricerche archeologiche hanno portato alla luce le strutture di un abitato a più riprese utilizzato sino al medioevo. Tra i ruderi compaiono case, cisterne, ampie grotte artificiali a probabile uso cultuale.
 Più in basso, sui versanti del monte coperti dalla fitta foresta a quercine, compaiono diverse sepolture a grotticella artificiale scavate nelle emergenze di quarzarenite. Dal medioevo il bosco, annesso al demanio della città di Nicosia, venne abitato da diversi eremiti che finirono per creare un convento attorno alla chiesetta di Santa Maria o di San Girolamo di Lartisina.
Più in basso, sui versanti del monte coperti dalla fitta foresta a quercine, compaiono diverse sepolture a grotticella artificiale scavate nelle emergenze di quarzarenite. Dal medioevo il bosco, annesso al demanio della città di Nicosia, venne abitato da diversi eremiti che finirono per creare un convento attorno alla chiesetta di Santa Maria o di San Girolamo di Lartisina.
Riserva naturale orientata del Monte AltesinaOggi del convento, detto Cummintazzu, rimangono i resti di una cascina utilizzata come rifugio dai frati, e parte delle strutture della chiesa. La comunità monacale sopravviveva con il ricavato del bosco e con la questua che veniva effettuata nelle masserie e nei borghi vicini.
I versanti della montagna, gestiti oggi dalla Azienda Demaniale delle Foreste, sono quasi interamente ricoperti da una fìtta foresta latifoglie composta essenzialmente da lecci, qui in trasgressione, posti cioè al di sopra della linea altimetrica che in genere ne limita la espansione, ad essi si alterna la roverella, quercia anch’essa ma spogliante, e nel sottobosco il pungitopo, l’edera, il ciclamino, la Dafne laureola, i cisti, l’ipocisto, i rovi e lo stracciabraghe.
Le radure, utilizzate per l’alpeggio delle mandrie, sono inverdite da ferle, erba medica, asfodeli bianchi e gialli. Fanno parte della fauna il picchio rosso maggiore, alcuni rapaci diurni come la poiana e lo sparviero e rapaci notturni, barbagianni, allocco e assiolo.
Frequente è la volpe e, più volte, è stato segnalato il gatto selvatico. La riserva, nei comuni di Nicosia e Leonforte, si estende per circa 744 ettari (593/2 di zona A e 150.7 di preriserva.
Riserva naturale orientata del bosco di Sperlinga e dell’Alto Simeto
Nel Piano Regionale dei parchi e delle riserve naturali, varato nel 1991, veniva prevista una ulteriore area protetta, capace di proteggere una ampia zona montana posta al confine tra le alture eree e le Madonie, incentrata sul Bosco di Sperlinga, una ampia foresta latifoglie decidua, caratterizzata da roverelle, un tempo di proprietà dei principi di Sperlinga e poi ereditata dal piccolo ed affascinante comune. L’area, grande ben 1.299 ettari con una zona A di 795 ettari ed una zona di preriserva di 504 ettari, posta nei comuni di Sperlinga e di Nicosia, comprendeva anche, soprattutto dopo una opportuna correzione della prima delimitazione, una parte della alta valle del fiume Salso Cimarosa, l’antico Kiamosoros, che, formato dall’unione dei fiumetti di Sperlinga e di Nicosia, inizia qui la sua corsa verso il bacino della diga di Pozzillo, sotto Regalbuto e poi verso il Simeto. Il corso d’acqua, con un alto contenuto salino dovuto all’erosione di depositi evaporatici dell’altipiano gessoso solfifero, ospita una ricca fauna eurialina, ovvero specializzata alla vita in acque salmastre. Le acque, a volte gonfiate dal disgelo delle nevi cadute sulle montagne circostanti, formano delle vallate ancora densamente vegetate da tamerici, cannucce, giunchi, e, incontrando le massicce lenti quarzarenitiche della zona, formano delle lunghe gole che compiono una larga curva a Sud dell’abitato di Nicosia. Purtroppo questa riserva è stata stralciata dal piano a causa di un ricorso presentato da cacciatori palermitani, ed è oggi sottoposta ad un feroce prelievo venatorio che impunemente depaupera il bellissimo ambiente naturale. La Unione Europea ha comunque istituito il Sito di Importanza Comunitaria del Bosco di Sperlinga, finitimo a quello delle alture gangitane del Monte Zimarra e del monte di Balza Pezzalunga, individuando una area di oltre cinquemila ettari che, con le sue stupende presenze naturali e antropiche, potrebbe divenire il nucleo di un futuro sistema integrato degli alti Erei.
Riserva naturale orientata del Vallone di Piano della Corte
Unica riserva della provincia di Enna ad essere stata affidata all’Università di Catania CUTGANA, venne istituita per la “conservazione e la tutela di un ambiente umido di particolare interesse botanico.”
Qui infatti, lungo il vallone scavato dalle acque che scendono da un crinale degli Erei per dirigersi verso la vallata del Dittamo, cresce ancora la fitta vegetazione a galleria che un tempo doveva coprire il corso della maggior parte dei fiumi dell’interno siciliano. Molte fanerofite ed emicrittofite, dominate dalla presenza di pioppo nero e gatterino, di salice bianco, delle capre e rosso, olmo minore e nocciolo a coprire canneti popolati da tifa mazzasorda, dal carice, dall’epilobio e dal giunco che le massaie agirine coglievano per avvolgervi intorno la pasta dei maccheroni di casa.
Questa galleria, oggi in alcuni tratti interrotta dall’attraversamento di strade interpoderali, è un’oasi di pace e di fresco.
Tra l’ombra degli alberi, luogo di ricovero per il picchio e per l’istrice, per la volpe e per il ramarro, cresce una prateria di equiseto che con i suoi sottilissimi rametti appena toccati dal sole acquista una parvenza eterea e quasi magica.
La riserva si estende lungo il fiume per circa 194,3 ettari (63,7 in Zona A e 130,6 in Zona B). È raggiungibile anche a piedi da Agira e può essere visitata sia chiedendo agli uffici centrali dell’Università
Riserva naturale integrale delle Forre Laviche del Simeto
Posta lungo il corso del Fiume Simeto, il maggiore dei corsi d’acqua siciliani, l’area protetta si estende nei territori comunali di Centuripe, Brente, Adrano e Randazzo per circa 291 ettari ben 285 dei quali in zona di mas-sima protezione. L’area protetta venne inserita nel piano, dopo una lunga battaglia condotta dalle associazioni ambientaliste ed in particolare da Legambiente, per conservare e tutelare il lungo susseguirsi di ingrottati lavici, con cascate, rapide, laghetti e forre che il fiume Simeto ha creato scorrendo tra le lave basaltiche di un’antica colata etnea. In questo ambiente selvaggio e panoramicamente di grande effetto, ha sede una comunità vegetale molto specializzata, capace di sopravvivere alle piene ed al caldo dell’estate, al morso
delle capre ed al gelo invernale, dando asilo ad una componente faunistica specializzata e rara. Tra le lave occhieggia l’oleandro, capace di sfruttare la benché minima opportunità di attecchimento, mentre nei dintorni, laddove i giardini di agrumi hanno lasciato spazio alla natura, fioriscono asfodeli bianchi e gialli, giunchi, prati ad ortica, papavero e tanaceto, ferie, borragine. Al sole si riscaldano la biscia, il ramarro e la lucertola wagleriana, mentre nelle acque s’odono i tonfi sordi dei tuffi della rana esculenta, del discoglosso e dell’ululone. Dove l’ingrottato sprofonda tra le lave per decine di metri il fiume viene superato dall’antico ponte dei Saraceni, costruito con un’ardita arcata a schiena d’asino, tutta in pietrame lavico misto a calcare bianco.
Il ponte in realtà non è saraceno ma un misto di diverse opere costruttive: le sue pile tutte rigorosamente dotate di struttura idrodinamica, sono di costruzione romana, probabilmente imperiale (I – II sec. D.C.) ed appartengono alle opere della strada Catina-Centorippe (Catania-Centuripe) che, come dicono diverse fonti antiche, rappresentava l’utostrada Palermo – Catania del tempo. In seguito al crollo venne costruito sulle pile romane almeno un altro ponte, aragonese, che, tra crolli e restauri si è mantenuto sino ai giorni nostri.
L’area che si auspica possa essere presto gestita dall’Università di Catania è il luogo ideale per il torrentismo.
Qui, infatti, e nella vicina gola di Bolo, profondissima, i più arditi possono recarsi all’interno degli ingrottati, tra le veloci acque, per ammirare in tutta la loro bellezza i giochi delle lave, pseudopoligonali, che incrociano i loro prismi in un effetto grafico di nero su nero che raggiunge il culmine cromatico nelle giornate di caldo sole primaverile.
Riserva naturale orientata dei boschi di Rossomanno, Grottascura e Bellia
Vasta 2.011 ettari (1.561 in zona A e 450 circa in zona B) l’area protetta copre una grande parte del territorio ereo posto tra i centri urbani di Piazza Armerina, Valguarnera ed Aidone. Il territorio è costituito dalla parte centro meridionale degli Erei, con cime relativamente basse, poste a circa 800 metri sul livello del mare, costituite da affioramenti litologici recentissimi dalle forme dolci ed attraversate da profondi solchi torrentizi tributari dei bacini del Simeto e del Salso Imera. Questi monti, sovrautilizzati nel tempo per la vicinanza ai centri abitati maggiori della provincia, vennero in parte lasciati boscati per favorime un uso civico alle popolazioni di Enna e Piazza che ne detenevano la proprietà demaniale. Fu così che arrivò ai giorni nostri una bella porzione di bosco fortemente antropizzato, poi implementato con piantagioni ad eucalyptus, ed oggi costituente il maggior demanio forestale del centro Sicilia.
Questa area, dominata dal pino domestico e dall’eucalipto, ma non di rado popolata anche da querce, lecci, sorbi, castagni, peri selvatici, e da un folto corteggio floristico erbaceo ed arbustivo, nasconde una lunga storia di utilizzazione umana. Qui, infatti, sorgeva un centro, nato nell’età del rame (come dimostrano vari resti di contrada Serra Casazze e di Serra Crovacchio) e vissuto sino al 1394, anno in cui, per punire il feudatario Scalerò degli Uberti, dichiarato reo di fellonia insieme ai Chiaramente, il paese di Rossomanno venne raso al suolo insieme agli altri feudi della fazione latina. I feudi vennero concessi alle Università delle vicine città demaniali e gli abitanti superstiti vennero deportati nelle stesse tant’è che ancora ai nostri giorni ad Enna esistono quartieri che parlano un dialetto differente dall’ennese, detto “funnurisanu” che altro non è se non il vecchio dialetto di Cundrò e Rossomanno. Del paese, posto sulla parte superiore della montagna omonima, rimangono diverse vestigia: l’acropoli siculo ellenizzata di Serra Casazze con un lungo muro di cinta munito di torrette di difesa, diversi lembi di necropoli con testimonianze di antichi riti incineratori e di deposizione a “campi di crani”, tombe circolari, case, magazzini, il basamento della torre feudale degli Uberti, una chiesetta tardo bizantina a tre navate con inumazioni a martyrion ed infine un convento, costruito sui resti del paese distrutto, ed utilizzato come eremo sino ad una cinquantina di anni fa. La riserva è quindi una sorta di parco archeologico immerso nel verde di un vasto bosco. Il territorio è facilmente percorribile sia a piedi che in mountain bike e sono molte le stradelle aperte al passaggio dei motorizzati. Una visita potrà iniziare dalla zona del vivaio forestale di Ronza, lungo la SS 117 Enna – Piazza Armerina. Qui l’azienda Demaniale delle Foreste, ente gestore della riserva, ha creato una delle maggiori aree attrezzate della Sicilia, capace di ospitare anche centinaia di persone, con sedili, panche, tavolini, fontane, voliere e chiudende ove pascolano cinghiali, daini, istrici. Il vivaio è anche attrezzato di biblioteca ambientale e di erbario, è sempre controllato da un guardiano ed al suo interno sta prendendo forma il nuovo Centro di Recupero per i Selvatici che verrà gestito dalla LIPU di Enna.
Vicino all’area della Ronza si potranno ammirare le incredibili forme delle pietre incantate, o pupi ballerini, una sorta di cerchio magico che la fantasia popolare ha voluto attribuire ad un sortilegio che pietrificò una danza sabbatica ma che in realtà sono il frutto della geologia del luogo. Da Ronza si dipartono decine di sentieri, tutti abbastanza facili se percorsi con una guida o, comunque, da chi, attrezzato di bussola e carta topografica saprà destreggiarsi nel bosco a tratti molto fitto.